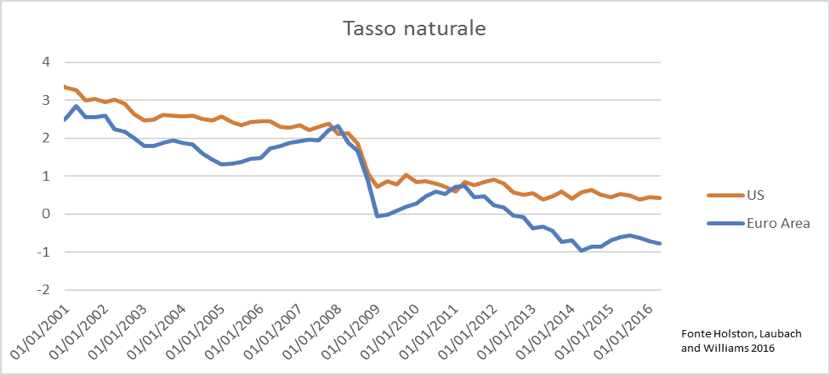Cavour, il protezionismo e la globalizzazione. Pensieri moderni di 165 anni fa
Nel 1851 Camillo Benso Conte di Cavour all’età di 41 anni guidava il Ministero dell’agricoltura e del Commercio del Governo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re di Sardegna. Nel mese di aprile di quello stesso anno il giovane Ministro dovette affrontare il dibattito parlamentare sul suo progetto di riforma doganale che prevedeva trattati commerciali con Belgio e Inghilterra e consistenti riduzioni dei dazi sino a quel momento vigenti.
A capo dell’opposizione protezionista il Conte Ottaviano Thaon di Revel fece osservare come il libero commercio nuocesse gravemente all’accumulo dei capitali all’interno del Regno di Sardegna e mettesse in serie difficoltà le imprese esposte alla concorrenza internazionale con conseguente flessione dei livelli occupazionali.
Cavour, che non fu mai un grande oratore ma i cui discorsi furono sempre chiari, asciutti e poco inclini alla retorica, replicò con un bellissimo intervento che riassunse le linee essenziali del suo pensiero in materia di politica economica e commerciale.
Con grande coraggio e lucida consapevolezza di come l’intervento dello Stato alterasse il libero gioco della concorrenza a vantaggio ora di questa ora di quella industria, Cavour esordì affermando che il suo Ministero professava “schiettamente il libero scambio”, e che fosse dell’avviso “che non si possa imporre alla generalità dei consumatori dazio veruno, onde favorire certi rami dell’industria…”
Il futuro Presidente del Consiglio dimostrò di comprendere appieno come il protezionismo non fosse altro che il risultato delle pressioni degli imprenditori più forti e capaci di rappresentare i loro interessi ai più alti livelli istituzionali ed una maschera, allo stesso tempo, con la quale si tentava di nascondere politiche distributive, utili solo a trasferire risorse dai consumatori ad alcuni produttori.
A chi insisteva nell’affermare che il protezionismo avrebbe consentito all’interno del Regno l’accumulazione di quei capitali di cui il sistema economico aveva necessità (sopratutto nei settori posti al riparo dalla concorrenza estera), il Conte di Cavour replicò dimostrando come in realtà il protezionismo alterasse proprio l’allocazione dei capitali poiché rappresentava un falso segnale capace di attirare risorse in settori protetti e per ciò solo incapaci di assicurare adeguato sviluppo e crescita.
Il sistema protettore non ha facoltà di creare capitali, ma solo che i capitali disponibili e destinati alla produzione si rivolgano a questo, piuttosto che a quell’altro ramo dell’industria – affermò Cavour, e più avanti precisò il suo pensiero dichiarando come – il sistema protettore abbia per effetto di spingere i capitali nelle vie che sono meno profittevoli.
Dimostrando grande capacità di leggere i fenomeni dell’economia mondiale il Ministro del Commercio illustrò le conseguenze nefaste che il protezionismo avrebbe avuto sulla divisione internazionale del lavoro e sulla capacità delle imprese (sopratutto in una realtà molto piccola come il Piemonte) di innovare e progredire perché stimolate dalla concorrenza esterna:
Ora, signori, il sistema protettore impedisce appunto la divisione del lavoro, col far sì che il capitale nazionale disponibile, il capitale di riproduzione, si rivolga a tutti quei rami d’industria di cui il Paese ha bisogno, ma i cui prodotti potrebbe procurarsi dall’estero; ma l’avere attivato tutti questi rami d’industria, riuscendo d’impedimento alla riunione dei diversi capitali in un’industria, impedisce appunto la divisione del lavoro, e ciò mi pare assolutamente evidente … ed accade sempre che mercè il dazio protettore, produttori si addormentano e sono lentissimi nei progressi che altrove si fanno celermente.
Cavour, infine, si fece carico (col garbo del linguaggio e la forza dell’argomentazione razionale) di svelare come l’idea degli industriali protezionisti di tutelare il lavoro dei loro operai per mezzo dei dazi fosse radicalmente sbagliata perché sottovalutava il profondo legale fra la quantità di capitali investita in un sistema economico e l’aumento della forza lavoro:
Se il sistema protettore avesse la virtù di aumentare i capitali, tornerebbe certamente proficuo alla classe degli operai: ma se invece di aumentare i capitali, non dà che un cattivo interesse, invece di tornare utile le torna dannoso. Potrà, egli è vero, essere di vantaggio ad una determinata località. È vero che il sistema protettore può favorire notevolmente, largamente, una provincia addetta ad una particolare industria … Ma bisogna vedere se il vantaggio che la valle d’Aosta ha ricavato dal dazio protettore sui ferri non sia stato pagato dieci volte dalle altre parti dello Stato.
Tutto questo nell’aprile del 1851,165 anni fa…
@roccotodero