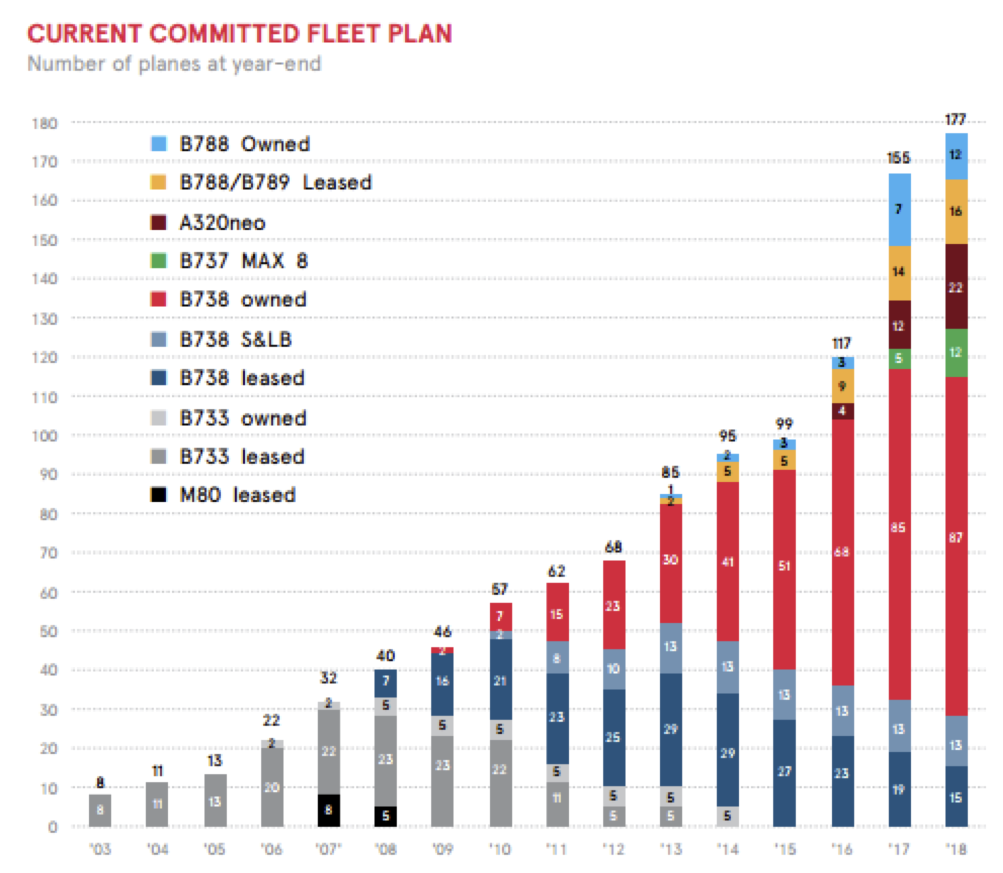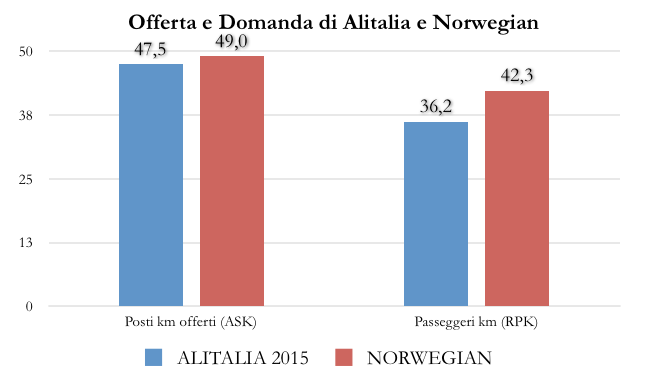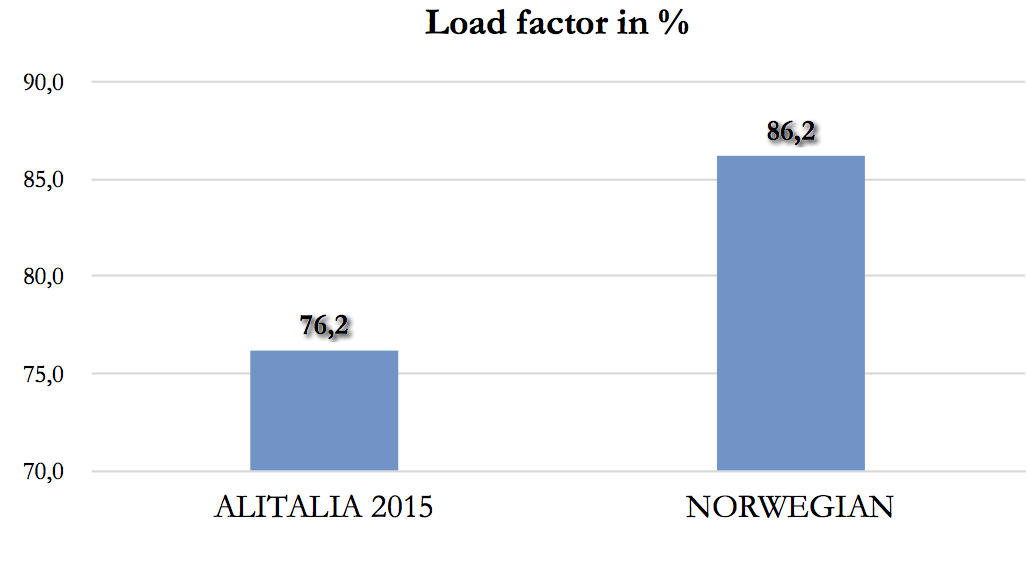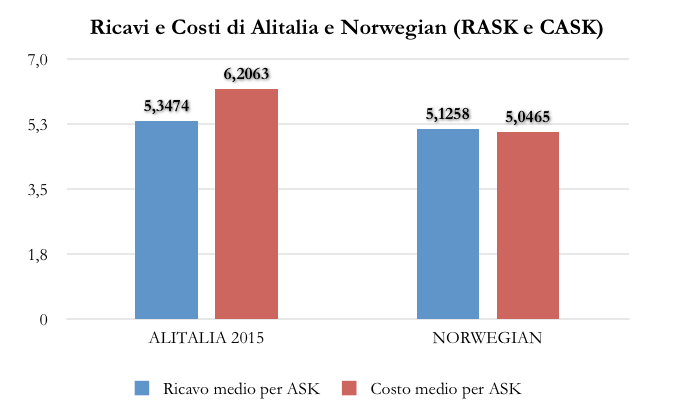A Roma, un’iniziativa “radicale” per la concorrenza
Se c’è una cosa che il calvario del ddl concorrenza ci ha insegnato, è che è inutile aspettarsi dal Parlamento italiano un passo in avanti – anche il più “cauto” possibile – verso una maggiore apertura dei mercati. Il processo di formazione delle leggi risente in maniera decisiva del peso delle lobbies e degli interessi organizzati: e i consumatori non sembrano godere di alcuna attenzione da parte di chi li governa. Ma se è inutile attendersi dal Parlamento un cambio di rotta, cosa resta da fare? Un suggerimento importante arriva da Roma, dove i Radicali hanno organizzato una raccolta firme per l’organizzazione di un referendum allo scopo di rompere il monopolio ATAC e mettere a gara il servizio di trasporto locale. Il trasporto di superficie e su rotaia a Roma è la plastica rappresentazione dei guasti dell’assenza di concorrenza: l’ATAC è, infatti, più che un’azienda “fallita”: è un completo disastro (rimandiamo a un utilissimo studio di Rosamaria Bitetti e Nicole Genovese [2016], che ne ha messo in luce tutti i numeri).
Le cause del disastro romano hanno molti padri (equamente distribuiti tra le varie amministrazioni comunali), ma un unico principio ispiratore: usare i soldi dei contribuenti per fare dell’ATAC un bacino clientelare per ottenere voti. Ciò spiega – come evidenziano sempre Bitetti e Genovese – il peso esorbitante e la scarsa produttività del personale dell’azienda. L’impatto di quest’ultimo sul totale dei costi, infatti, è a Roma pari al 47%, circa il doppio che a Londra (25%), con soltanto un terzo circa dell’offerta. Guardando il livello delle retribuzioni, l’ATAC paga stipendi medi superiori di circa 4000 euro rispetto a quelli della sua equivalente parigina, nonostante il PIL regionale sia notevolmente più alto nella seconda città. È scontato concludere, allora, che l’ATAC esiste principalmente per garantire posti di lavoro e, solo incidentalmente, per offrire un servizio (scarso) alla collettività. Il “bene comune” che i politici vogliono tutelare è la propria leva d’influenza, non il trasporto pubblico.
Con il referendum proposto dai Radicali e la messa a gara del servizio le cose potrebbero davvero cambiare. E non lo diciamo facendo della pura speculazione. Nel 2014, Ugo Arrigo e Andrea Giuricin realizzarono, per l’Istituto Bruno Leoni, un confronto tra i costi e l’efficacia dei servizi resi da ATAC e da TPL, un consorzio che gestisce, sempre nella città di Roma, servizi residuali (notturni e periferici): il costo medio per dipendente di ATAC risultò del 24 per cento superiore a quello di Roma TPL; mentre una vettura chilometro di ATAC risultò costare 7,33 euro a fronte dei 4,54 euro di Roma TPL. Come mai queste rilevanti differenze? Presto detto: al contrario di ATAC, TPL ha ottenuto la concessione del servizio solo a seguito di una gara a evidenza pubblica. Basta davvero poco – un’iniezione di concorrenza nel sistema – perché il consumatore, anche quello romano, possa godere di un servizio efficace ed efficiente.
Ci sia però consentito un piccolo e conclusivo appunto. Nel presentare i quesiti referendari, i Radicali Roma hanno sostenuto che «tra privatizzazione e liberalizzazione c’è una grande differenza» e che l’urgenza è liberalizzare, non privatizzare. Chi scrive è dell’avviso che quella tra “liberalizzazioni” e “privatizzazioni” sia, in realtà, una falsa dicotomia, atteso che la libera concorrenza può esistere davvero solo tra soggetti privati tutti uguali di fronte alla legge (e al potere pubblico) e che, pertanto, non si può liberalizzare senza prima aver privatizzato. Ma poco importa: in un momento storico come quello attuale, in cui qualsiasi nuova iniziativa economica in grado di beneficiare i consumatori viene prontamente bloccata a colpi di emendamenti “a sorpresa” o di discutibili sentenze, un’iniziativa “radicale” a favore della concorrenza è una bellissima notizia. Se si riuscissero ad aprire alla concorrenza i servizi del comune di Roma, tra i più chiusi e oppressi del Paese, si conseguirebbe una vittoria “effettiva” per i cittadini romani e “simbolica” per tutti gli altri italiani. Ecco perché il referendum “Mobilitiamo Roma” va sostenuto con tutte le energie e gli sforzi possibili.