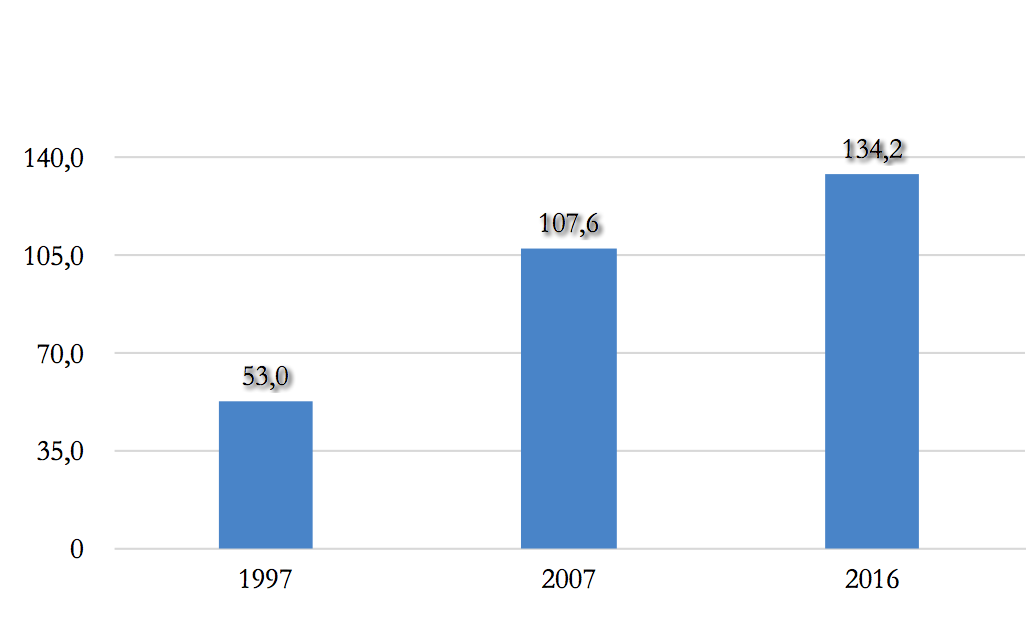L’#acqua pubblica tra retorica e realtà – L’#Hashtag di Serena Sileoni
Davvero l’emergenza idrica a Roma non si poteva prevedere? Ed è un problema dovuto a scarsità della risorsa, o a una sua cattiva gestione? Risponde Serena Sileoni nel suo #Hashtag.