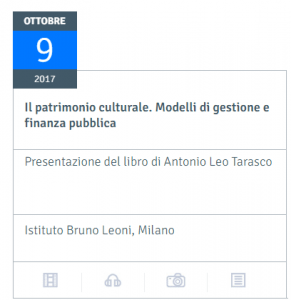La giustizia amministrativa in Italia—di Matteo Repetti
Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Matteo Repetti.
Giustizia amministrativa. E se avessero ragione gli inglesi (anche sulla Brexit)?
In questi ultimi anni, parlare della giustizia amministrativa, dei giudici amministrativi, dei TAR, è piuttosto difficile (ma cosa non è difficile, ormai, in questo paese?): la discussione è pesantemente condizionata dalla cronaca, il dibattito risulta piuttosto schizofrenico (i TAR annullano i provvedimenti dell’amministrazione, ritardano le procedure di gara, bloccano i cantieri, bisogna ripartire da capo, ecc.; no, non è vero, sono un presidio fondamentale contro l’inefficienza e la corruzione, c’è bisogno di legalità, ecc.).
Per descrivere per quanto sommariamente il funzionamento della giustizia amministrativa in Italia può essere utile prendere come riferimento – a contrario – l’ordinamento britannico, che storicamente neppure riconosce l’esistenza del diritto amministrativo come branca del diritto e che sostanzialmente non conosce l’istituzione di un giudice speciale amministrativo (anche se al tempo della Brexit può risultare un’operazione un po’ fuori moda).
Parlando di pubblici poteri e diritto amministrativo, forse si potrebbe dire che tutto ruota intorno alla discrezionalità amministrativa ed al buono (o cattivo) uso che la pubblica amministrazione ne fa. Che poi è semplicemente un altro modo di trattare della risalentissima questione relativa alla distinzione tra diritti soggettivi pieni ed interessi legittimi.
In ragione della preminenza dell’interesse pubblico – di cui in qualche modo la P.A. è portatrice – nei sistemi di diritto amministrativo continentale è riconosciuta una posizione di supremazia dell’amministrazione rispetto ai soggetti privati ed ai cittadini (in ragione dell’influsso esercitato dall’ordinamento francese e, ancor prima, per i motivi storico-culturali rappresentati dall’esperienza delle monarchie assolute continentali e dalla dottrina dello stato etico).
Se è vero che la pubblica amministrazione è costituzionalmente vincolata al principio di legalità, ai precetti posti dalla legge, è altrettanto vero che è dotata di sue speciali prerogative, direttamente derivanti dalla dottrina della separazione dei poteri costituzionali, legislativo, esecutivo e giudiziario.
Non così succede, invece, nell’ordinamento britannico, dove è fondamentale la cd. rule of law, intesa, nelle sue varie implicazioni, come assoluta prevalenza della legge, del diritto comune, del parlamento, della volontà del corpo elettorale espressa mediante libere elezioni, rispetto ad ogni altro potere costituito (corpo amministrativo e giudiziario). Ciò è tanto vero che da quelle parti, pur essendo avvertita la necessità di contenere e contemperare i pubblici poteri (i famosi checks and balances), la dottrina della necessità costituzionale della separazione dei poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario – ritenuta immanente negli ordinamenti continentali, è sostanzialmente sconosciuta.
Per intenderci, in Inghilterra i giudici sono tradizionalmente nominati tra i migliori avvocati del regno, e non esiste qualcosa di comparabile alla classe giudiziaria come la conosciamo ad esempio in Italia (con organi di autogoverno, rappresentanze sindacali, ecc.).
Solo recentemente, per effetto delle pressioni esercitate dall’ordinamento comunitario (a cui sembrava inconcepibile la figura del Lord Cancelliere sostanzialmente a capo del potere giudiziario), nel Regno Unito è stata istituita la Corte Suprema. E non è un caso che il sistema britannico non conosca un sindacato di legittimità costituzionale operato da un organo giudiziario, che rappresenta invece la normalità nell’Europa continentale.
In ogni caso, si è detto, nell’ordinamento inglese, in virtù della forza pervasiva ed assorbente della rule of law, intesa come assoluta prevalenza della legge e del parlamento rispetto al potere amministrativo e giudiziario, da una parte viene contestata la stessa esistenza del diritto amministrativo, dall’altra si è storicamente ritenuto che l’istituzione di un giudice speciale amministrativo costituisse una deroga al generalissimo principio di uguaglianza davanti alla legge (e fosse in definitiva espressione di privilegi, come teorizzato da Dicey più di un secolo fa).
Nei paesi di cd. diritto amministrativo, invece, come il nostro, c’è un giudice speciale a cui sono sostanzialmente devolute le questioni e le vertenze in cui è parte una pubblica amministrazione. Anche in Italia, sulla falsariga del modello francese, è stato istituito il Consiglio di Stato e, nel corso degli anni ’70 del secolo scorso, i TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Ma, fatta tutta questa premessa, come funziona la giustizia amministrativa in Italia?
Beh, diciamo innanzitutto che, da un punto di vista organizzativo, la giustizia amministrativa ha, mediamente, tempi di definizione del contenzioso accettabili, se parametrati a quelli della giustizia ordinaria, di quella civile si intende; in particolare, tradizionalmente è piuttosto rapida la definizione delle istanze cautelari (da qualche tempo anche nelle forme dei provvedimenti resi inaudita altera parte in caso di particolare urgenza).
Riguardo alle caratteristiche del procedimento, nonostante l’evoluzione degli ultimi anni – recepita anche a livello normativo nel nuovo codice del processo amministrativo – come tratto fondamentale il giudizio rimane sostanzialmente di natura impugnatoria (di annullamento dei provvedimenti amministrativi): in buona sostanza, fondamentalmente il giudice amministrativo annulla gli atti amministrativi ritenuti illegittimi. Ciò, nonostante gli sforzi compiuti riguardo alla necessità di passare dal sindacato sull’atto a quello sul rapporto, ovvero sul procedimento amministrativo da cui poi è scaturito l’atto asseritamente viziato.
A questo proposito, basti pensare che, riguardo all’istruttoria ammessa, non è previsto che siano sentiti testimoni od assunte altre prove orali, tutto essendo basato su carte e documenti; ed al posto della consulenza tecnica d’ufficio, per accertare situazioni di fatto rilevanti ai fini di causa tradizionalmente ci si arrangia con altri strumenti d’indagine (cd. ispezioni e verificazioni), spesso demandati a soggetti che fanno anch’essi parte dell’amministrazione, che tuttavia non garantiscono a sufficienza l’assoluta imparzialità dell’accertamento da compiere e spesso neppure un adeguato approfondimento tecnico.
Ma, d’altra parte, l’intera dogmatica continentale ha sempre avuto come oggetto d’indagine privilegiato i vizi dell’atto amministrativo, in un gesuitico e sfinente sforzo di rielaborazione, che cosa si può pretendere adesso? (Gli inglesi no, per loro il provvedimento amministrativo non esiste quasi come nozione, quello che conta è che il procedimento sia fair, sia equo).
E’ da segnalare, poi, il progressivo aumento delle materie (urbanistica ed edilizia, appalti, servizi pubblici, concessioni, espropri, silenzio dell’amministrazione, ecc.) di cd. giurisdizione esclusiva, ovvero delle situazioni in cui le vertenze sono devolute interamente al giudice amministrativo, non distinguendosi più tra diritti ed interessi legittimi. In particolare, il deficit di tutela per il cittadino si verifica nei casi in cui viene avanzata una domanda di risarcimento danni (che, tradizionalmente, non è mai stato il mestiere del giudice amministrativo).
Qualche considerazione va poi fatta relativamente ai meccanismi di reclutamento dei giudici amministrativi. Nei ruoli della magistratura amministrativa si arriva solo in esito a concorsi di secondo livello, e tendenzialmente si attinge tra la dirigenza degli impiegati pubblici. Se in genere ciò garantisce rispetto al grado di preparazione tecnica dei giudici amministrativi, è innegabile come, non fosse altro che per affinità di carriera ed idem sentire, il sistema si esponga a qualche censura, essendo auspicabile una maggiore terzietà.
Tuttavia, almeno a parere di chi scrive, il principale difetto del sistema della giustizia amministrativa in Italia non è tanto l’omogeneità dei giudici rispetto alla P.A., né la sopra citata natura del giudizio, modellato più sulla falsariga del ricorso amministrativo che su quella di un vero e proprio processo. L’aspetto che maggiormente desta perplessità è la stessa idea della teorizzata necessità che le vertenze in cui è parte una P.A. debbano essere devolute a giudici speciali anziché al cd. giudice naturale. Ma così operando, si assiste alla automatica creazione di un ulteriore contropotere, inevitabilmente al centro di interessi ed intermediazioni (di cui, in un paese dalle mille corporazioni e degli infiniti poteri di veto come il nostro, non si sente davvero la mancanza). Insomma, non esattamente in linea con i principi della rule of law anglosassone di cui si è detto sopra.
Si aggiunga che, da un punto di vista più tecnico-giuridico, la stessa coesistenza di una duplice giurisdizione – ordinaria ed amministrativa – fatalmente determina, pressoché in qualunque vertenza in cui è parte una P.A., la preliminare e sfiancante definizione delle immancabili eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice effettivamente adito, a scapito del merito delle questioni: solo in base a questa banale considerazione, sarebbe probabilmente ragionevole riunificare la giurisdizione.
Per concludere, con una provocazione (ma neanche troppo): forse aveva ragione Giannini quando, presentando la versione italiana del manuale di diritto amministrativo inglese di Wade alla fine degli anni ’60, manifestava ammirazione per il bistrattato – dalla tradizione amministrativistica continentale – sistema britannico. D’altronde, ci sarà un motivo se nel mondo si parla inglese (e se avessero ragione gli inglesi anche sulla Brexit?).