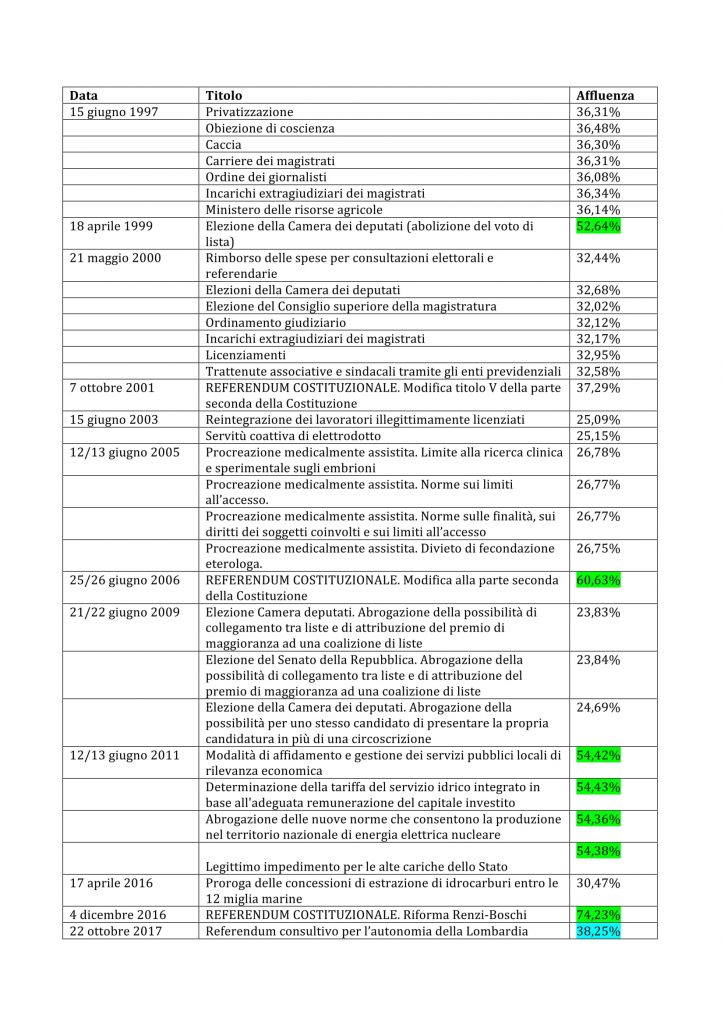Repetita iuvant: vendere quote del tesoro alla Cassa Depositi e Prestiti non significa privatizzare.
Dopo Enav, ecco Eni. Il “nuovo” programma di privatizzazioni del governo sembra finalmente prendere forma. Stando alle ultimissime notizie, l’esecutivo punta a recuperare circa 2,5 miliardi di euro dalla vendita della quota del Tesoro in Enav e dalla cessione del 2,15% della quota del Tesoro in Eni a Cassa Depositi e Prestiti (CdP) entro la fine dell’anno. Inutile ricordare come queste operazioni siano, oggi come sempre, delle semplici partite di giro (a.k.a. finte privatizzazioni).
Nonostante la CdP rimanga fuori dal perimetro contabile della pubblica amministrazione, essa è una Cassa finanziata e controllata al 100% dal pubblico. Ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze controlla l’82,77% del capitale della CdP, il 15,93% è detenuto da una folta schiera di fondazioni bancarie, mentre l’1,3% è controllato dalla CdP stessa, attraverso Azioni proprie. Di conseguenza, l’idea di vendere alcuni “gioielli di famiglia” alla CdP non è da considerarsi assolutamente una privatizzazione. Contrariamente alla definizione di privatizzazione, in questa circostanza il governo non farebbe ricorso al mercato, né sposterebbe la proprietà di un ente o di una società dal controllo statale a quello privato.
Non è un caso che, come riporta anche Bloomberg, questa mossa rischia di essere completamente snobbata dagli investitori. Secondo molti analisti, infatti, questa “privatizzazione all’Italiana” rimuoverebbe dal bilancio statale un’entità pubblica mantenendola essenzialmente sotto il controllo governativo, senza ridurre in alcun modo la presenza dello stato all’interno dell’economia.
Dopo un già misero 2016 (in cui il MEF è riuscito a raccogliere solo lo 0,1% del PIL dalle “privatizzazioni”), il Governo ha previsto per l’anno in corso una forte riduzione del target delle privatizzazioni. Mentre nel DEF 2016 si parlava di proventi derivanti dalle privatizzazioni pari allo 0,5% per gli anni 2016, 2017 e 2018 (una cifra attorno agli 8 miliardi all’anno per tre anni), oggi il governo punta a recuperare solo lo 0,2% del PIL. Troppo poco per ridurre il debito pubblico e per cercare di mettere in sicurezza finanze pubbliche che paiono essere sempre più fragili e mal gestite.
Nel corso degli ultimi anni la Cassa Depositi e Prestiti è tornata prepotentemente al centro della politica industriale italiana. Dopo aver assorbito pezzi crescenti d’industria, tra cui Snam, Terna, Fincantieri, Eni, Saipem Ansaldo Energia, il colosso in mano al MEF è ora pronto a comprare tutta la quota del Tesoro in Enav e metà delle rimanti quote del Tesoro in Eni. Mentre la CdP ha ormai assunto tutte le sembianze di una nuova IRI, all’interno del governo regna la confusione più totale e – per ora – di vere privatizzazioni meglio non parlarne.