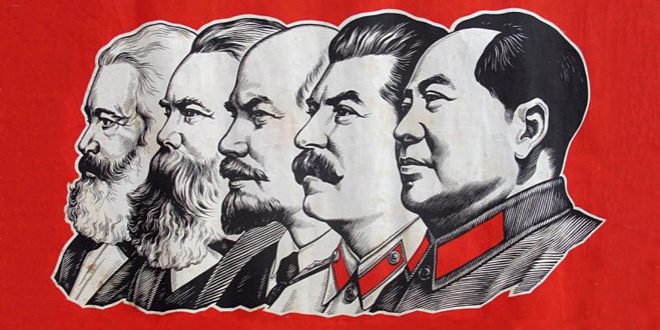Il diritto alla casa non può passare per la negazione della proprietà
In una fresca giornata di primavera di quattro anni fa, trecentocinquanta persone occupavano illegalmente un intero edificio in via Caravaggio, a Roma. Era l’inizio di un vero e proprio incubo: la denuncia, sporta dai proprietari dell’immobile immediatamente dopo l’occupazione, cadeva nel vuoto. Tutti erano stati messi al corrente: la procura, la polizia, il questore, il prefetto e il sindaco di Roma. Eppure, nessuno tentò di sgomberare l’edificio. Nei giorni successivi gli occupanti manomisero le centrali termoelettriche, la rete idrica e quella antincendio, oltre a svolgere abusivamente alcuni lavori di ristrutturazione. I proprietari, a quel punto, presentarono una richiesta di sequestro preventivo alla procura, ma non bastò nemmeno questo. Il sequestro fu disposto, ma mai attuato.
Di storie come questa se ne potrebbe raccontare tante. Solo a Roma sono centinaia gli immobili occupati, uno addirittura da tredici anni, senza contare le violazioni che non riguardano interi edifici ma singole unità immobiliari. E del resto non è un mistero che le occupazioni abusive, nell’ordinamento italiano, costituiscano reato solo in teoria. Negli ultimi anni si è assistito a un graduale affievolimento della tutela della proprietà nei loro confronti: sempre più spesso infatti le occupazioni abusive sono valutate dai decisori pubblici e dai tribunali, nei loro effetti e problemi connessi, contemperando esigenze e interessi diversi: dal principio alla legalità all’ordine pubblico, dalla dignità personale al diritto all’abitazione; in questo bilanciamento, tuttavia, il diritto di proprietà non rientra quasi mai, se non indirettamente.
Alla base di questo sconsiderato disprezzo per il diritto di proprietà c’è la convinzione che tenere in considerazione altri diritti nel bilanciamento con quello di proprietà conduca verso una società più umana e ‘giusta’. Ma si tratta di un’illusione: in questo modo si procede a passo spedito, piuttosto, verso una società in cui non vi è certezza del diritto e in cui, quindi, ogni assunzione di responsabilità e ogni investimento divengono esercizi di speranza verso la benevolenza di uno Stato arbitrario, che decide di riconoscere o negare i diritti di proprietà con un semplice gesto del pollice.
Di storie come quella dell’immobile di via Caravaggio, dicevamo, ce n’è tante. Ma è la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha chiuso, almeno temporaneamente, la vicenda, a costituire un precedente importante. I giudici, infatti, hanno riconosciuto che lo Stato ha l’obbligo giuridico di impedire l’occupazione di un edificio o quantomeno di adottare, in un lasso di tempo ragionevole, le misure necessarie per porvi fine. Non aver agito per oltre quattro anni, nel caso in questione, ha pertanto compresso illegittimamente i diritti fondamentali del proprietario. E la responsabilità di tutto questo – conclude la sentenza – è del Ministero dell’Interno, da cui dipendono le forze di polizia incaricate dell’esecuzione del sequestro quattro anni fa. Con conseguenze molto concrete: il Tribunale ha infatti condannato il Ministero a pagare al proprietario quasi 300mila euro al mese, da quando fu disposto il sequestro preventivo fino a quando l’immobile sarà finalmente liberato.
È una sentenza significativa, questa, non solo per il precedente che crea, ma soprattutto perché mette a nudo con grande chiarezza l’ipocrisia di uno Stato che – non riuscendo a garantire un diritto sociale – lo pone in contrasto con altri diritti, in questo caso quello di proprietà. E che, così facendo, dimostra tre volte la propria inefficacia: nel non riuscire a garantire il diritto all’abitazione agli occupanti, nel non riuscire a garantire il diritto di proprietà ai proprietari, e nell’essere pertanto costretto a rimborsare questi ultimi con i soldi dei contribuenti. Un monito, speriamo, per comprendere finalmente che il riconoscimento del diritto all’abitazione non può passare per la negazione del diritto di proprietà.
Twitter: @glmannheimer