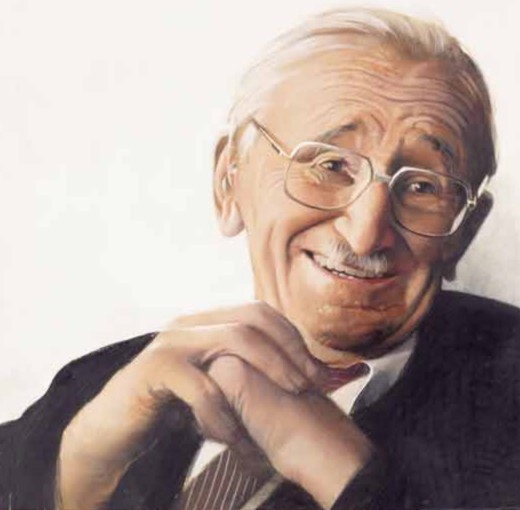Eppur si muove
Dopo la condanna in primo grado inflitta da un tribunale svedese a The Pirate Bay, sembrava che il dibattito sul ripensamento delle attuali logiche del copyright dovesse subire una battuta d’arresto. Per questo sorprende – in positivo – l’apertura della Siae alla diffusione telematica delle opere attraverso una semplice dichiarazione dell’autore. Forse un nuovo approccio alla tutela della proprietà intellettuale è alle viste? Nel frattempo, consiglio di non mancare il dibattito on-line che l’Economist sta dedicando al tema, all’insegna della convinzione che «existing copyright laws do more harm than good».