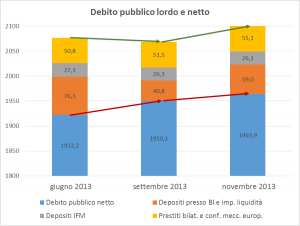Differenza indefinitamente privilegiata.
A volte sorge il dubbio che l’appartenenza al genere femminile venga reputata da talune donne quasi una differenza “privilegiata”, idonea cioè a conferire prerogative che debbano essere legislativamente garantite e non effettivamente conquistate. L’argomento è quello delle c.d. quote rosa nelle liste elettorali, materia di attualità in questi giorni. Al fine di favorire l’equilibrio in ambito politico, la proposta di legge recentemente elaborata dispone, “a pena di inammissibilità”, che nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento e che, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, non possano esservi “più di due candidati consecutivi del medesimo genere”. Alcune parlamentari non hanno gradito le prescrizioni sopra riportate in quanto, pur sancendo la parità della presenza femminile e maschile nelle liste e, quindi, eguali possibilità di accesso, prevedono l’alternanza di due a due esponenti per sesso: un effetto finale realmente paritario in sede elettorale non sarebbe, pertanto, garantito. Le parlamentari suddette chiedono misure idonee a incidere più decisamente sui risultati. Non hanno, forse, considerato che la Consulta si è già più volte espressa sul punto e, come si vedrà in prosieguo, pur cambiando nel tempo orientamento, seguendo la profonda evoluzione della materia delle pari opportunità sotto più di un profilo, ha tuttavia continuato a sostenere l’illegittimità di disposizioni che tendano a determinare esiti elettorali predefiniti in funzione del sesso di appartenenza.
La parità di genere è stata normativamente raggiunta ormai da tempo. Alle donne è stato consentito il pieno esercizio di ogni diritto fondamentale, nonché lo svolgimento di professioni in precedenza precluse, facendosi cessare ogni discriminazione prima esistente. In aggiunta a tali azioni “positive”, anche la Costituzione è stata modificata al fine di incentivare azioni di “promozione” nei confronti di coloro le quali in passato erano state oggetto di disparità di trattamento a opera dell’ordinamento, oltre che a causa di fattori psicologico-culturali insiti in buona parte della collettività nel suo complesso. L’art. 117, comma 7, Cost., introdotto con la legge costituzionale n. 3/2001, ha previsto che le leggi regionali “rimuovono ogni ostacolo che impedisce a piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso (…) alle cariche elettive”. L’art. 51, comma 1, Cost., poi, che nella formulazione originaria si limitava a sancire l’eguaglianza alle condizioni di accesso alle cariche elettive, a seguito della legge costituzionale n. 1/2003 ha stabilito che a “tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. La formulazione delle norme menzionate rende evidente che le stesse sono finalizzate a dare impulso alla presenza femminile in ogni ambito di interesse e non, invece, ad attribuire privilegi e vantaggi differenziati.
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate la Consulta, nel pronunciarsi su specifici articoli della legge elettorale della Valle d’Aosta (sent. n. 49/2003) e della Campania (sent. n. 4/2010), ritenne che gli stessi, in quanto formulati in modo “neutro”, si limitassero a consentire la parità effettiva fra uomini e donne nelle cariche elettive mediante misure preordinate esclusivamente a favorire eguali opportunità nella competizione elettorale e non, invece, tendenti ad assicurare garanzie di risultato. Le pronunce sopra menzionate si ponevano in contrasto con una precedente (sent. n. 422/1995) nella quale la Corte, chiamata a sindacare la norma secondo cui nelle liste di candidati ai Consigli dei Comuni con popolazione fino a n. 15.000 “nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi” ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale. L’aveva, infatti, reputata discriminatoria in quanto non solamente finalizzata a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento da parte delle donne di determinati risultati, bensì idonea ad attribuire loro direttamente quei risultati e tale, pertanto, da “creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate”. Gli effetti della sentenza erano stati conseguentemente estesi a tutte le diverse norme contenenti “limiti, vincoli o riserve nelle liste di candidati in ragione del loro sesso”: tra le altre, quella della legge n. 277/1993 secondo cui le liste (bloccate) presentate ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale dovevano essere formate da candidate e candidati in ordine alternato. Nonostante con le due citate sentenze successive la Corte abbia poi sovvertito quanto affermato nel 1995 e, quindi, consentito la previsione di quote nell’ambito delle liste elettorali, tuttavia essa ha mantenuto fermo il principio per cui le disposizioni preordinate al riequilibrio sono legittime solo se tali da non incidere “sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”. Esse non possono, pertanto, tendere a predeterminare un risultato “di genere” in sede elettorale. Eppure, questo è l’obiettivo perseguito dalle parlamentari cui si faceva riferimento che, con l’appello formulato, hanno inteso riproporre quanto la Consulta, pur nell’evoluzione del proprio orientamento, ha continuato a ritenere non consentito. Esse hanno, quindi, reputato insufficiente la mera misura promozionale già contenuta nel testo presentato, volta a favorire pari opportunità di candidabilità e, quindi, di conseguenza, pari opportunità di eleggibilità, richiedendo invece norme tendenti a garantire alle donne la certezza del risultato. La soluzione così proposta non sembra tenere conto di altri criteri volti a valorizzare merito e preparazione del candidato. Si tratta di un profilo che è stato più volte affrontato (qui e qui qualche esempio): quote finalizzate ad attribuire posizioni rilevanti in relazione al genere di appartenenza e non ad altre competenze finiscono per ottenere l’opposto rispetto a una situazione di parità di condizioni di partenza idonee ad assicurare a esponenti di ambo i sessi le medesime chances di farsi valere. Questo era, peraltro, il senso delle pronunce della Corte Costituzionale: ma, al di là di esse, altre considerazioni sembrano necessarie.
In Italia continuano a ritenersi auspicabili, nonché a essere predisposte, misure di favore nei riguardi della partecipazione femminile a ogni ambito di interesse al fine di colmare il divario esistente, nel presupposto che esso origini da discriminazioni concrete. Tuttavia, non essendo consentita dall’ordinamento alcuna disparità di trattamento, forse a discriminazioni c.d. implicite si fa riferimento: ma su pregiudizi di tipo psicologico o culturale non è la legge che deve operare, perché essa non ha compiti di “ingegneria sociale”. Gli strumenti in forza dei quali incentivare la partecipazione delle donne alla vita politica, nonché al lavoro e ad altri settori in generale, sono diversi. Ancor più importante è rilevare come le misure suddette vengano introdotte senza che sia fissato un limite quantitativo o temporale volto a delimitarne la portata: norme attributive di vantaggi dovrebbero sempre essere funzionali al conseguimento di un fine predeterminato, raggiunto il quale perderebbero ogni ragione di operare. Ciò è essenziale in un ordinamento che trovi effettivo fondamento sul principio di eguaglianza sostanziale, tra gli altri; che faccia della trasparenza degli obiettivi da conseguire il metodo in base a cui operare; che sia in grado fondatamente di motivare le soluzioni prescrittive che sceglie di attuare. Ma con riguardo alle misure volte a colmare il divario tra sessi in ogni ambito sociale i criteri menzionati non sempre sembrano valere. Per cui non è dato sapere fino a quando si riterranno necessarie azioni di promozione in favore delle donne; qual è il limite oltre cui, finalmente, queste ultime non dovranno più essere considerate appartenenti a una specie da tutelare o, comunque, destinatarie di una sorta di rendita di posizione, come oggi accade; qual è l’obiettivo raggiunto il quale potrà reputarsi che la parità effettiva sia stata ottenuta. A tal fine, potrebbe giovare la fissazione di una specifica percentuale nelle assemblee parlamentari o in altri contesti dove si tenda al riequilibrio in argomento, ovvero un determinato limite temporale, come nella legge Golfo-Mosca, ad esempio. Altrimenti, si corre il rischio di applicare misure che, favorendo un genere, finiscono per tradursi nello svantaggio dell’altro e quindi in una discriminazione di risultato, senza che un obiettivo prefissato possa far ritenere conseguito il fine voluto, in mancanza di un termine chiaro e definito alle politiche così adottate. Il principio appena esposto trova espressa conferma nel CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women): l’art. 4, nel prevedere “misure temporanee speciali” finalizzate ad accelerare l’uguaglianza di fatto tra uomini e donne, dispone che esse non devono “assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte”, ma devono essere abrogate non appena raggiunti i loro obiettivi in materia di uguaglianza di opportunità e di trattamento.
Vi è ancora un ulteriore profilo che deve essere considerato. Esigenza attualmente oltremodo sentita è quella che si pervenga a una semplificazione normativa volta ridurre la regolamentazione particolareggiata di profili che possano essere demandati alla autodisciplina dei soggetti interessati. Quest’ultima consente talora di ottenere risultati anche migliori rispetto a quelli di prescrizioni di legge che, oltre a comprimere la libertà privata, appesantiscono l’ordinamento, aumentando la complicazione dello stesso con previsioni di dettaglio. Specificamente, disposizioni frutto di autoregolamentazione, se violate, possono indurre una perdita di stima reputazionale che produce un disvalore maggiore dell’applicazione di altre sanzioni. In materia di divario di genere, trattandosi di argomento “sensibile” nella percezione della collettività sociale, può ritenersi che questo effetto sarebbe amplificato (qui il tema era stato già affrontato). Pertanto, misure volte a garantire la parità tra i sessi, compresa una sistemazione alternata tra uomini e donne nell’ambito di liste bloccate, potrebbero essere predisposte da parte dei diversi partiti senza necessità dell’imposizione in via autoritativa. Il ricorso all’autodisciplina nella materia in esame viene auspicato dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza del 1995: essa afferma che regole volte a colmare i divari in discorso, “costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi pervenire con un’intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l’effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare”. Nella menzionata sentenza, peraltro, la Consulta cita la risoluzione n. 169 del 1988 con cui il Parlamento europeo ha invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili, facendone scaturire la preferibilità di soluzioni diverse da quelle legislative al fine di ottenere il risultato voluto.
Può, quindi, concludersi che l’appello delle parlamentari da cui si sono prese le mosse non può essere condiviso, anche al di là dei profili di legittimità costituzionale sopra rappresentati. La continua richiesta di sanare il divario esistente mediante scorciatoie e corsie preferenziali rischia ancor più di relegare le donne nell’ambito di una “categoria protetta” a cui certi risultati vanno garantiti a causa di risorse “di genere” evidentemente per natura insufficienti, quindi inidonee a consentire loro di partecipare paritariamente a competizioni con esponenti del sesso opposto. Tale affermazione sembra essere aggravata dalla circostanza che, come visto, non viene di norma fissato alcun obiettivo o limite raggiunto il quale cessino le misure di favore predisposte: quasi che per il legislatore nazionale il disequilibrio non possa essere colmato, sì che i criteri di merito e valore essenziali per giudicare chi partecipi a una qualsivoglia competizione debbano ritenersi necessariamente sostituiti da quelli dell’appartenenza a un genere “ad libitum” svantaggiato. Affinché i pregiudizi culturali possano essere superati, preparazione e capacità personale rappresentano strumenti importanti per assicurare l’eguaglianza. Chiedendo indefinitamente che siano loro garantiti favori, le donne dimostrano di aspirare a una privilegiata differenza causata da carenza di migliori risorse: è bene pensarci.
Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono in alcun modo l’ente di appartenenza (Consob)