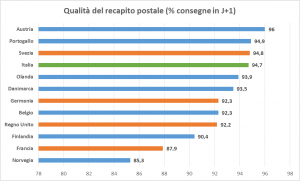Multe ai giornalisti per l’uso improprio delle parole?—di Gianfilippo Cuneo
Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Gianfilippo Cuneo.
Che l’Italia sia in una situazione disastrosa è evidente; i colpevoli sono molti, ma c’è una categoria che è particolarmente colpevole ed è quella dei giornalisti. La colpevolezza è aggravata dal fatto che per obbligo professionale i giornalisti dovrebbero informare, ed invece disinformano, magari inconsciamente, con un diffuso uso sbagliato delle parole da loro scelte per descrivere le situazioni. I cittadini disinformati poi hanno attese irragionevoli, fanno scelte politiche errate ecc.: quindi il danno è grave e bisogna intervenire, magari con multe salate a chi usa le parole sbagliate.