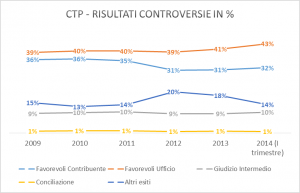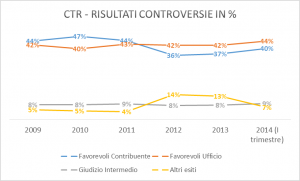La malattia degenerativa dello statalismo: il caso dei sussidi ferroviari
Uno dei grandi problemi dell’espansione dello Stato è che crea problemi rispetto ai quali la soluzione sembra sempre e solo essere più Stato. Su LeoniBlog.it, Ivan Beltramba ha scritto un rovente articolo contro le disposizioni contenute nel decreto competitività, che avviano un processo di riduzione degli sconti sui prezzi elettrici per gli operatori ferroviari.
Si tratta di una misura che va parzialmente incontro a quanto l’Istituto Bruno Leoni chiede da tempo: per le ragioni illustrate da Beltramba, dal 1963 le Ferrovie dello Stato (e poi, con la sommaria liberalizzazione, anche gli operatori privati del settore) godono di una riduzione sui prezzi dell’elettricità, finanziata da tutti i consumatori (non dai produttori, come viene erroneamente sostenuto nel pezzo) attraverso una specifica componente tariffaria (A2) il cui gettito è stimabile attorno ai 400 milioni di euro / anno. Questa forma di sussidio incrociato è doppiamente inefficiente: in primo luogo perché è iniqua dal punto di vista distributivo (se proprio si ritiene che il trasporto ferroviario debba godere di un trasferimento di quelle dimensioni, non c’è ragione di imputarlo al consumatore elettrico, che già paga prezzi tra i più alti d’Europa, e non alla fiscalità generale). Inoltre gli effetti di questo balzello sono probabilmente regressivi. Secondariamente si tratta di una mancanza di trasparenza, perché di fatto questo sconto non viene conteggiato tra i trasferimenti ai trasporti ferroviari e quindi determina una sistematica sottostima del volume di risorse che ogni anno gli italiani versano nelle casse dei ferrovieri.
Il DL91 non abolisce la componente A2, ma ne limita l’ambito di applicazione al solo servizio universale: come dire, nella misura in cui gli operatori ferroviari svolgono un servizio pubblico (in particolare il trasporto pendolari) è in qualche modo accettabile che essi gravino sul consumatore elettrico. Ma quando offrono servizi a mercato, questa agevolazione non ha ragione di esistere. In fase di conversione del decreto, la Camera ha ridotto la portata del provvedimento, mantenendo gli sconti per il trasporto merci.
Si tratta dunque di un piccolo passo nella giusta direzione, che è quella di limitare i trasferimenti di denaro da una tasca a quell’altra. Naturalmente restano molti altri problemi da risolvere, sia in ambito ferroviario (la separazione della rete, l’enforcement della disciplina della concorrenza, ecc.) sia in altri campi (i vari sussidi all’autotrasporto che lo stesso Beltramba ricorda). Ma è davvero ironico difendere un sussidio in virtù dell’esistenza di un altro sussidio: questa logica è uno scudo impenetrabile a difesa dello status quo. Se si vuole davvero iniziare a ridurre la dimensione dello Stato e il suo ruolo nell’allocare le risorse dei privati, da qualche parte bisogna pur cominciare. Questa volta il governo ha iniziato da qui.