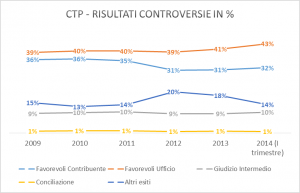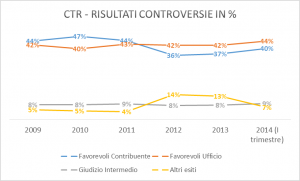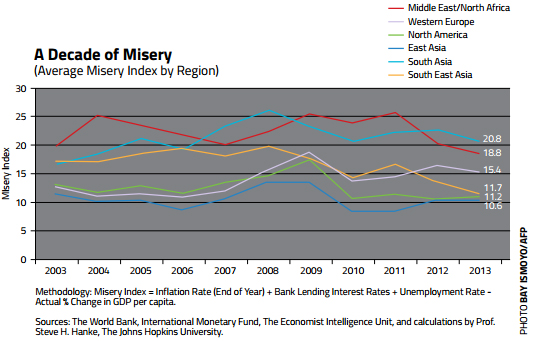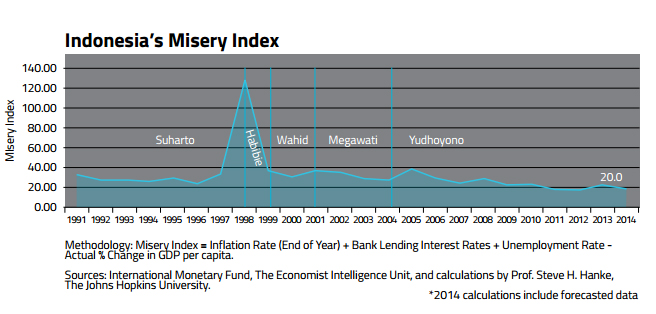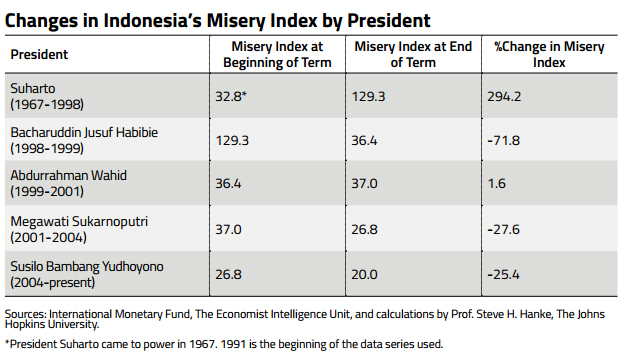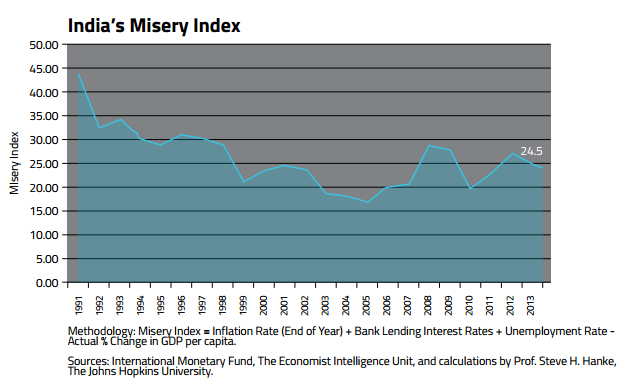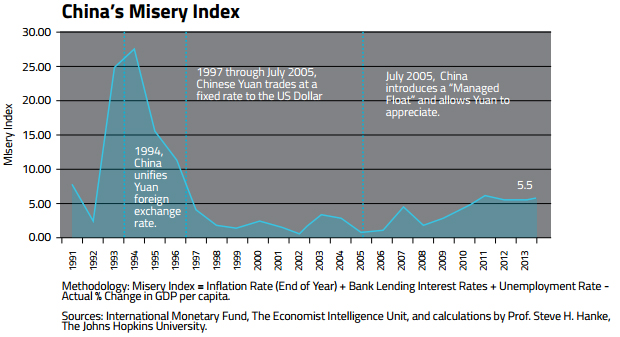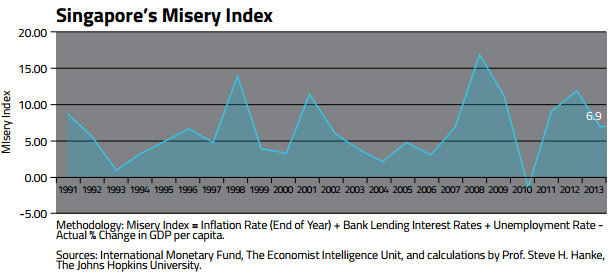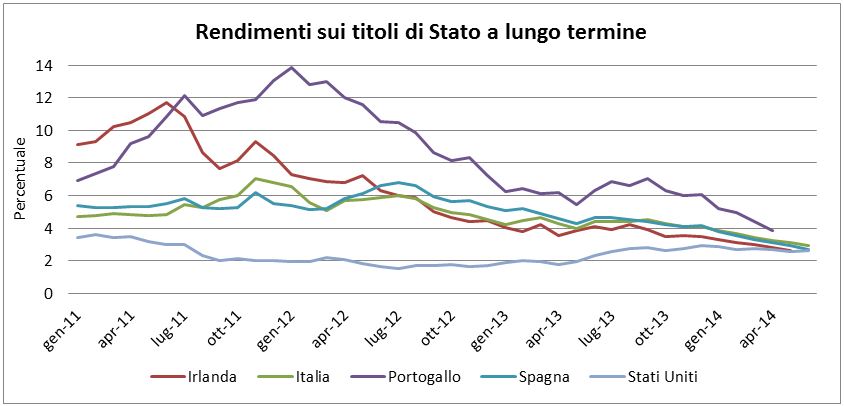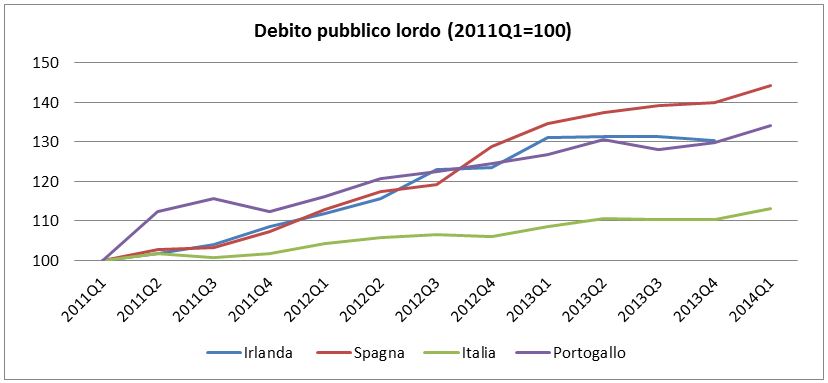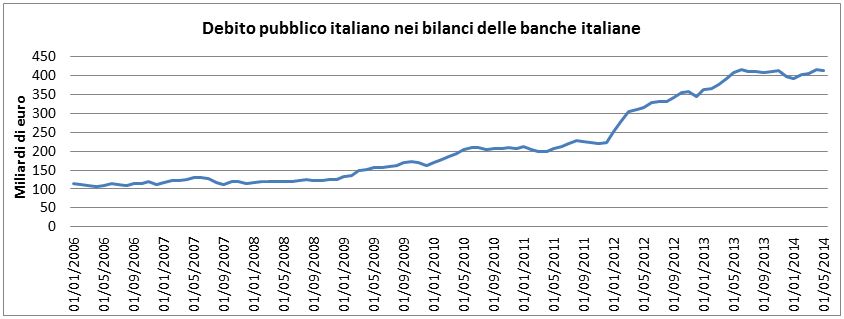Rismontare l’età pensionabile? Perché dissento dall’on Damiano (e da mezzo Pd oltre alla Cgil)
“Obbligare tutti ad andare in pensione a 67 anni avrà come risultato aziende popolate di anziani e bloccherà per lungo tempo l’ingresso dei nostri figli nei luoghi di lavoro. Non lamentiamoci poi se aumenta la disoccupazione giovanile”. Riparto dalla conclusione delle osservazioni rivoltemi ieri sul Mattino dal presidente della Commissione Lavoro della Camera, onorevole Cesare Damiano, che ringrazio calorosamente per l’attenzione e la gentilezza riservata alla mia analisi sul nodo Cottarelli-Renzi. Per inciso: conosco Damiano da anni, e ho imparato a stimarne il garbo con il quale argomenta il suo punto di vista, e il rispetto che rivolge a interlocutori che non lo condividono. Quando si affrontano temi di forte impatto come i conti pubblici e le pensioni, che hanno un enorme rilievo finanziario ma insieme impattano la vita di milioni di italiani, discutere con reciproco rispetto è cosa preziosa. Con altrettanta cortesia, desidero spiegare perché le sue ragioni non mi convincono. L’onorevole Damiano fa battaglia fin dal ptrimo momento contro il brusco innalzamento dell’età pensionabile disposto dalla riforma Fornero, fine 2011. Non ha mai condiviso quella riforma, e da allora contropropone – per le ragioni che ho ricordato all’inizio – di tornare ad abbassare l’età pensionabile.
Nell’attuale 2014 per le pensioni di vecchiaia servono 66 anni e 3 mesi di età per gli uomini, 63 e nove mesi per le donne lavoratrici dipendenti, 64 e nove mesi per le lavoratrici autonome. Per le pensioni di anzianità servono 42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 e mezzo per le donne. Ma sotto i 62 anni di età si paga pegno sull’entità dell’assegno. Nell’esame parlamentare del decreto sulla PA emanato dal governo Renzi, si vogliono fare dei passi indietro rispetto a queste nome generali. Il trattamento di anzianità ai dipendenti pubblici a 62 anni esclude i requisiti minimi contributivi che valgono per tutti gli altri lavoratori, e l’assegno è pieno. C’è poi il caso dei 4mila insegnanti per i quali si torna ad applicare la possibilità della pensione con la “quota 96” – come somma di età anagrafica e versamenti contributivi – che aveva introdotto Damiano quando era ministro,.
La Ragioneria Generale dello Stato è dovuta intervenire smentendo le magre stime e coperture predisposte in Parlamento, e ha messo nero su bianco le cifre: nel solo 2014 il ritorno della “quota 96” nella scuola comporta un aggravio di 45 milioni di euro, e l’abbattimento dei disincentivi per i prepensionati pubblici comporta 165 milioni di maggior spesa pubblica di qui al 2018 (all’opposto, si sommano anche i 147 milioni di aggravi in 7 anni per la protrazione in servizio fino a 68 anni disposta per i professori universitari e i primari, insieme ai magistrati che restano fino a 75 anni io li chiamo “i protetti di Stato”…).
Ci sono due modi di guadare a questi voti parlamentari avvenuti col sostegno del governo. La prima è a bocce ferme, la seconda in prospettiva. A bocce ferme, c’è innanzitutto un problema evidente di iniquità: perché ad alcune categorie di dipendenti pubblici viene riservata una facoltà che ai lavoratori comuni è negata. Non mi pare proprio accettabile. Anzi, a mio personale giudizio è intopllerabile. E c’è poi un problema finanziario: governo e parlamento son onaturalmente liberi di decidere, ma quantificando con scrupolo gli oneri e per favore fronteggiandoli con tagli veri e immediato di spesa, invece di far correre ancora deficit e debito.
Ma l’onorevole Damiano invita a considerare le cose in prospettiva. Per questo ha salutato come positive tali novità, vedendovi la premessa di una generale e radicale ridiscussione della riforma Fornero, da parte del governo Renzi. Egli avanza un insieme di proposte che vanno dal ritorno alla pensione a partire dai 62 anni di età per tutti ma con penalizzazioni a seconda dei versamenti effettuati (una penalizzazione in termini attuariali non equivalente alla maggior spesa previdenziale ma assai inferiore, e dunque con oneri trasferiti alla fiscalità generale) alla quota 100 come somma di età anagrafica e contributiva, dall’adozione del calcolo contributivo per chi sceglie il prepensionamento, al prevedere sempre e comunque con un minimo di 35 anni di contributi. Il ministro Poletti ha confermato in questi giorni che il governo sta esaminando le diverse ipotesi, sia pur con una mano più pesante sui disincentivi. Al contempo, le cronache di stamane vorrebbero che il governo receda invece esattamente da ciò che entusiasma Damiano, accogliendo in tutto o in parte i rilievi della Ragioneria Generale contro le modifiche previdenziali avvenute in parlamento sul decreto di riforma PA , e io mi auguro che sia davvero così.
La battaglia di Damiano non mi convince, per tre ragioni.
La prima riguarda proprio l’equazione proposta da Damiano: più alta è l’età previdenziale, meno sono i giovani occupati. E’ una formula di facile presa, tanto più in un Paese in ginocchio dopo 7 anni di crisi. Ma ha il torto di considerare l’occupazione come una torta “ferma”, di cui dividere le fette tra diverse classi di lavoratori in conflitto generazionale. Al contrario, per recuperare nel tempo i 6 milioni di occupati che ci mancano per eguagliare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro tedesco (12 milioni se guardiamo ai paesi scandinavi), dobbiamo ragionare in termini non stazionari ma dinamici: abbassando le imposte troppo alte a lavoro e e impresa (dunque tagliando la spesa) e con un welfare meno ostile a donne e famiglie. Abbiamo bisogno insieme di più anziani al lavoro e di più giovani al lavoro, non di cosiddette “staffette generazionali” levati-tu-che-mi-ci-metto-io, per accrescere reddito e produttività.
La seconda ragione è l’equilibrio dei conti previdenziali. Damiano sa bene che la brutalità della riforma Fornero a fine 2011 è stata dovuta ai traccheggiamenti che la politica ha riservato per decenni alle pensioni. La riforma Dini del 1995 spalmò gli effetti del passaggio al contributivo – che resta però un sistema a ripartizione, cioè sono i lavoratori attivi a pager i loro contributi le pensioni erogate ai beneficiari – in un orizzonte pluridecennale, e tenne in piedi età basse per i trattamenti che davano diritto alle pensioni di anzianità. Ed è vero che nel 2013 la spesa previdenziale è stata pari al 16,3% del PIl e sarebbe andata al 18%, senza riforma Fornero. Ma non va dimenticata una cosa. Il rapporto sulla sostenibilità di lungo periodo della spesa previdenziale che la Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato tre mesi fa, sia pur adottando generose stime di crescita del PIL (media annua più 1,5%) e dei tassi di occupazione, vede la spesa previdenziale a scendere di un soffio sotto il 15% del PlL solo al 2030, per poi risuperarlo nel 2040, scendendo al 14% solo nel 2060. E’ vero che nei paesi Ue e Ocse nel frattempo la spesa sale, ma sale partendo da punti molto più bassi della nostra: per i paesi OCSE la spesa previdenziale salirà dal 9 all’11,5% del Pil entro il 2060, per i paesi UE dall’11% al 13%. Quei 2-3 punti di Pil di spesa previdenziale italiana annua maggiore della media dei paesi avanzati descrive una scelta che resta sbagliata: continuiamo a spendere troppo poco per le politiche attive del lavoro e per il sostegno della famiglia e della curva demografica, e troppo invece in politiche passive (oltre 100 miliardi in CIG da inizio crisi senza una sola ora di riformazione e riavviamento al lavoro delle centinaia di migliaia di soggetti interessati) e in pensioni ai “privilegiati” del sistema retributivo puro (non è colpa loro, ovviamente, è la politica ad averlo scelto).
E’ una scelta sbagliata non solo in termini di giustizia tra generazioni e all’interno delle stesse generazioni, visto che i trattamenti tra pubblici e privati, dipendenti e autonomi non sono affatto eguali. E’ sbagliata anche perché l’INPS non ce la fa, e deve attingere alle tasse di noi tutti. Nel bilancio finanziario INPS 2013, l’istituto ha registrato un saldo negativo di 9,8 miliardi. E’ un deficit per i nove decimi dovuto allo sbilancio tra contributi raccolti e trattamenti erogati ai pensionati del settore pubblico, l’ex Inpdap. Ma lo sbilancio finanziario di quasi 10miliardi annui dell’INPS da solo non dice tutto. Se andiamo a vedere però le diverse fonti di entrata rispetto alle poste di spesa, al netto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato i contributi raccolti nel 2013 dall’INPS sono pari a 209,9 miliardi euro (153 dai privati, 55 dal settore pubblico, 1 dai lavoratori dello spettacolo), mentre la spesa diretta in pensioni è pari a 266,8 miliardi. Come si vede, tra contributi ed erogazioni puramente previdenziali lo sbilancio è stato nel 2013 di 56 miliardi, Ed è il contribuente con le tasse, a pagare dolorosamente la differenza.
Di qui la terza ragione: una vera spending review è più che mai necessaria. Siano i tecnici e i politici a farla insieme, sia solo la politica a farla e basta ( e su questo ho molti dubbi), l’essenziale è farla. Senza tagli sugli acquisti pubblici – è stata appena rinviata la decisione che era stata annunciata, di passare da 35mila stazioni d’acquisto a poche decine: perché? – e sulle tantissime voci di spesa inefficiente – in Sicilia i dirigenti pubblici vanno in pensione a 53 anni ad assegno pieno: perché? – non abbassiamo le imposte, non creiamo lavoro, non diminuiamo la pressione che lo sbilancio previdenziale porta tutti gli anni a carico del contribuente. So che Damiano su questo la pensa diversamente da me. Ma lasciar fuori dalla spending review sanità e previdenza, cioè ben oltre il 40% degli 800 miliardi di spesa pubblica complessiva – è un errore grave, anzi gravissimo: quello sì, che lo pagheranno amaramente i nostri figli.