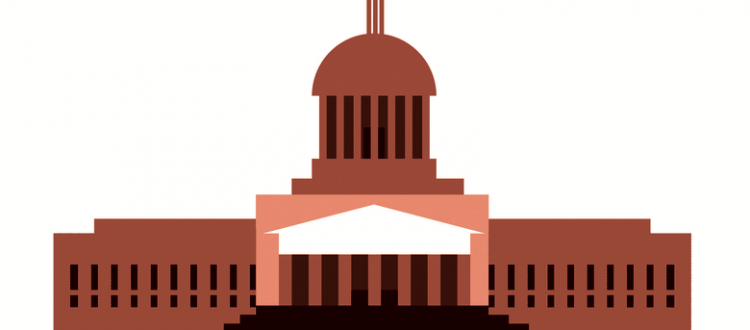Il pregiudizio legislativo—di Matteo Repetti
Non è vero che c’è sempre bisogno di riforme e nuove leggi
Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Matteo Repetti.
In Italia si è da qualche mese ormai insediato il nuovo governo ed il dibattito, sui media come al bar, è preso dalle necessarie ed improrogabili riforme di cui ha bisogno il paese (lo avete già sentito, vero?): si va dal cd. decreto dignità e dalle modifiche riguardanti il mercato del lavoro alla nuova legittima difesa e alle misure antimmigrazione, dalla flat tax alle pensioni, dall’inasprimento delle norme anticorruzione alla lotta alle disuguaglianze, passando per l’inevitabile riconoscimento legislativo dei nuovi diritti.
Ma siamo proprio sicuri che le cose debbano funzionare così? Quello dell’inevitabile riforma legislativa è davvero un fenomeno, un destino ineluttabile?
Dalle nostri parti, vale per la cultura giuridica accademica ma anche per il sentire comune, per l’opinione dell’uomo della strada, per governare una collettività è condizione essenziale – si pensa – produrre regole, che saranno evidentemente nuove, emanare leggi, legiferare.
È quello che gli addetti ai lavori chiamano giuspositivismo, che è un tratto comune della storia giuridica dell’Europa continentale e che risale al processo di codificazione degli stati nazionali ed ha poi trovato nuovo impulso nei principi della rivoluzione francese: il diritto è il prodotto dell’attività legislativa, la legge e i codici. Nulla preesiste, di giuridicamente vincolante, alla produzione legislativa, che interviene a disporre quello che è giusto o sbagliato facendo tabula rasa dell’assetto precedente, ipotizzando e presumendo di poter di volta in volta illuministicamente plasmare una società nuova e migliore. Chi la pensa diversamente è un ingenuo, che ancora non ha capito la differenza tra il diritto, che solo ha validità ed efficacia vincolante erga omnes, e le convinzioni morali e personali di ciascuno.
Ma è realistico pensare che per governare una comunità, con la sua storia, le sue tradizioni, il suo senso di appartenenza, si possa ogni volta tirare una riga su comportamenti ritenuti leciti fino ad un istante prima, modificare repentinamente e bruscamente convinzioni ed abitudini, disattendere affidamenti? (E ciò, si badi bene, a prescindere dalla evidente e patologica ipertrofia legislativa tipica della nostra storia repubblicana, per giunta recentemente aggravata dalla burocrazia comunitaria, che aggiunge un surplus di confusione ed incertezza).
Forse non è necessariamente così. Le persone sanno in genere cosa è giusto e cosa è sbagliato, quello che si deve o non si deve fare: nelle famiglie non ci sono disposizioni scritte per regolare i comportamenti dei propri membri (se mia figlia non vuole fare i compiti probabilmente devo evitare di fornirle un accurato decalogo con l’indicazione delle punizioni conseguenti); nei posti di lavoro, se il clima è buono e produttivo non c’è bisogno di regole di condotta dettagliate; sull’autobus, la buona educazione è forse più importante delle minuziose condizioni generali del contratto di trasporto; la pedante normativa anticorruzione – che sostanzialmente si risolve nella richiesta agli interessati una sorta di autocertificazione di virtuosità – garantisce effettivamente dai comportamenti illeciti?
Probabilmente è allora arrivato il momento di provare a fare qualche riflessione più generale. Storicamente, la stessa nozione di diritto per come la intendiamo noi oggi è un’invenzione degli antichi romani. Ebbene, per i romani, le norme che disciplinano una comunità, una città, non vengono create dal legislatore, ma preesistono e vengono in qualche modo rinvenute dai giudici così come un linguista codifica le regole grammaticali dall’effettivo uso che ne fa chi parla e scrive una certa lingua. Le collettività, per funzionare, hanno bisogno di comportamenti reiterati e regole potremmo dire immanenti, che si creano e perfezionano nel tempo in una sorta di moto browniano di tutti i soggetti che fanno parte di quella comunità (che ricomprende gli antenati, i presenti e quelli ancora non nati), sulla base di senso di appartenenza, convinzioni religiose e morali, aspettative di reciprocità, timori di riprovazione sociale.
Solo nella decadenza dell’impero si assiste ad un’inflazione di senatoconsulti (i decreti legge dell’epoca), mentre il diritto romano classico è fondamentalmente consuetudinario e pretorio, rinvenuto appunto dai giudici sulla base dei comportamenti rilevati. Nell’antica Roma si sapeva che i debiti dovevano essere pagati perché era giusto farlo e che diversamente si era puniti, quali erano i diritti del proprietario, in che cosa consisteva una famiglia, chi doveva ereditare in caso di morte (la codificazione degli istituti giuridici fondamentali è avvenuta solo successivamente).
Non è forse un caso che, a distanza di tempo, la modernità, per come la conosciamo oggi, abbia la forma degli ordinamenti anglosassoni.
Anche da quelle parti il diritto, le regole, ciò che è giusto o sbagliato, è per buona parte consuetudinario e prescinde dalla contingenza dell’attività legislativa. Così come per i prati all’inglese – per cui serve prendere un terreno, dissodarlo ed irrigarlo per qualche centinaio d’anni -, allo stesso modo la convivenza sociale si basa su principi secolari, sul rispetto delle libertà individuali fondamentali e dei principi di correttezza e buona fede nei contratti e negli affari – la fairness – che spesso prescinde dalla formalizzazione scritta, realizzandosi invece una lenta e costante opera di rinvenimento e sistematizzazione da parte dei giudici in ossequio al fondamentale rispetto del precedente.
A parte la classica e un po’ demodé iconografia british (del tipo gli inglesi rispettano le code), si può portare un esempio meno usurato.
Da quando sono disponibili gli smartphone e le nuove piattaforme elettroniche che hanno rivoluzionato il settore della mobilità urbana (si pensi ad Uber), nell’Europa continentale si sono succedute mille ipotesi di regolamentazione legislativa del fenomeno, che hanno avuto come conseguenza una conflittualità ed un contenzioso enorme, ed hanno di fatto ostacolato l’utilizzo di una nuova tecnologia che oggettivamente rappresenta un progresso per la collettività (a meno che non si voglia pensare che avevano ragione i luddisti quando distruggevano i telai e si opponevano alle macchine a vapore nel ’700).
Nel mondo anglosassone, più empiricamente ci si è chiesto se l’utilizzo di questi nuovi strumenti era adeguato (fit), e quando il Comune di Londra è stato rassicurato – fondamentalmente riguardo alle condizioni di sicurezza per gli utenti – sulle concrete modalità con cui il servizio veniva svolto, la licenza a Uber è stata rinnovata per via amministrativa, senza necessità di provvedimenti legislativi formali e regolamentazioni rigide.
D’altra parte, ci sarà un motivo se a scuola studiamo ancora il latino ed oggi nel mondo si parla inglese (nonostante la Brexit)?