American Petroleum — di Massimo Nicolazzi
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un estratto dall’articolo “American Petroleum” di Massimo Nicolazzi, comparso sul numero speciale di Limes “Quel che resta della terra”.
Dice che l’Inghilterra, senza il carbone, sarebbe giusto rimasta un’isola. Prova a togliere in quell’altro secolo il petrolio all’America. Magari succedeva che l’Inghilterra rimaneva l’Inghilterra; e gli Stati d’Europa persino dei soggetti politici. Il dominio, a volte, ha anche un fondamento energetico.
Il petrolio d’America. Quello che gli ha cambiato il mondo. Gli americani sono stati i primi e i migliori a saperlo coniugare a tecnologia e processi industriali (dai motori, peraltro creazione europea, al fordismo come modello produttivo, alle nuove tecniche di raffinazione che moltiplicavano le rese di distillati «leggeri» e perciò i volumi di petrolio da cui potevi fare benzina); però erano anche quelli che ne avevano tanto, e più di tutti.
Grandissimi consumatori. Nel 1925, per citare il primato, consumavano da soli il 70% della produzione petrolifera mondiale; e più della metà ancora per anni dopo il secondo dopoguerra. Però anche grandissimi produttori. Nel 1927 producevano in casa il 71% dell’intera produzione mondiale;rimasero esportatori netti dall’inizio della storia del petrolio sino al 1948; e ancora nel 1960 rimanevano i primi produttori al mondo (se pur con una quota ridotta al 33% della produzione). (…)
Il secolo americano. Tanto petrolio prodotto o da produrre a casa propria, che fa da volano insostituibile al modello di sviluppo. Un industry nazionale di forte impatto occupazionale e con ricadute sensibili sui redditi di molte famiglie, concentrate soprattutto negli Stati produttori. Un controllo stretto e pressoché diretto sulla produzione del petrolio fuori d’America, col Medio Oriente che negli anni Cinquanta si fa quasi cinquantunesima stella e i prezzi del suo petrolio inchiodati per quasi vent’anni poco sopra il dollaro a barile. E però un controllo che è più controllo del mercato mondiale e dunque strumento di politica estera che non una necessità del sistema economico interno, se ancora per tutti gli anni Sessanta col sistema delle quote (che se non sono un embargo selettivo poco ci manca) possono permettersi in media di limitare l’importazione a circa il 10% dei consumi nazionali.
Poi arriva il 1973. Opec, embargo, ascesa incontrollabile dei prezzi. Nel 1980 si bissa (al netto dell’embargo). In otto anni il barile schizza da poco più di un dollaro a poco meno di quaranta. E loro scoprono di non averne. O quantomeno di non averne abbastanza. La produzione interna declina. Magari tra protezionismo e declino c’è una relazione; ma è comunque troppo tardi per pensarci. Dal 1968 scoprono annualmente meno di quanto producono; insomma gli peggiora il rapporto riserve/produzione. Il controllo del mercato mondiale gli evapora in pochi mesi. Forse, come la storia successiva a partire dalla quotazione del petrolio al Nymex sembra avvalorare, è l’avvisaglia e la premessa della nascita di un mercato vero; e non la sua negazione. Però l’idea stessa di dipendere da un mercato sembra intollerabile. Fuor dei bizantinismi della politica estera, fino al 1970 non c’era un tema di security del supply. C’era la property del supply. Che per importarlo lo comprassero era giusto una rappresentazione contabile. Quello mediorientale era comunque loro. Adesso per via di nazionalizzazioni ed altro salta la public-private partnership con le oil majors. Il petrolio bisogna andare a comprarselo per davvero. Negoziarlo con entità statali. Comprarlo a prezzi la cui determinazione sfugge al controllo. «Dipendere» da altro e da altri. La versione di Locke con cui avevano attraversato l’oceano applicata al petrolio recitava di liberty e property. «Commerce» non c’era scritto. La rottura della relazione biunivoca property/security è perciò devastante, e lascia il posto all’ossessione della security tout court.(…)
La mission impossible del ritorno all’indipendenza si è giocata, per il petrolio, essenzialmente su tre tavoli. Due confessi e proclamati. Efficienza/risparmio e sostituzione con biofuel. La prima ha prodotto tra l’altro i Cafe (Corporate Average Fuel Economy) standards, e dunque limiti al consumo unitario medio del parco automobili prodotto da ogni casa automobilistica. Il secondo, largamente sussidiato, ha portato alla diffusione di carburanti E-10 e, seppure sino ad ora più limitatamente, E-15, e dunque alla vendita di carburante contenente rispettivamente un 10 o un 15% di etanolo. Poi c’è il terzo tavolo. Pudicamente velato. L’ambiente. (…)
Correva l’anno 2005. L’anno dell’Energy Policy Act del presidente Bush. L’anno che gli Stati Uniti raggiunsero il loro massimo di consumi petroliferi. Quasi 21 milioni di barili/giorno. Per la precisione 20 milioni e 802 mila. Non fu l’anno che produssero meno. Però quasi, e fecero leggermente peggio solo l’anno dopo. Comunque in tutto quasi 7 milioni di barili. Per la precisione 6 milioni e 895 mila.
Compariamolo con l’adesso. 2011, consuntivo. Consumi: 18 milioni e 835 mila. Produzione: 7 milioni e 841 mila. Il forecast 2012 segnalerebbe un’ulteriore piccola contrazione dei consumi dell’ordine dei 300 mila barili/giorno; e un aumento della produzione di ulteriori 600 mila barili/giorno. (…)
Nel 2005 importavano 13,7 milioni di barili/giorno di greggio e prodotti, e ne esportavano 1,165 milioni. Nel 2011 hanno importato 11,5 milioni; e però esportato quasi 3 milioni (…) Nel 2005 dipendevano dalle importazioni di petrolio e derivati per oltre il 60,3% dei loro consumi. (…) Nel 2012 la stima è che (…) la dipendenza dall’import scenda intorno al 42% .
Sin qui, tradotto, significa che dal 2005 gli Stati Uniti hanno «liberato» e rilasciato sul mercato più di quattro milioni e mezzo di barili/giorno che prima si compravano loro. Se guardate le variazioni d’origine dell’import, i barili «liberi» aumentano ancora. Il primo importatore è il Canada, cui forse più che come a un importatore dovremmo pensare come l’altro pezzo di un sistema nordamericano sempre più integrato. Nel 2005 esportava negli Stati Uniti 2,1 milioni di barili. Quest’anno ci si avvicina ai 3 milioni. Arrotondando, il sistema nordamericano in pochi anni ha «restituito» al mercato degli altri grosso modo 5 milioni e mezzo di barili/giorno che prima importava da fuori. Grosso modo il 15% della produzione mondiale. Se poi sembrano pochi, forse giova ricordare che i consumi italiani sono sotto il milione e mezzo al giorno. O che la Cina ne importa poco più di 5. O che dal 2005 al 2012 l’aumento combinato dei consumi di petrolio di Cina e India è stato ampiamente inferiore ai 5 milioni di barili. Insomma che la riduzione sul mercato mondiale delle importazioni petrolifere americane ha più che compensato la contemporanea crescita dei consumi indiani e cinesi. Il risorgimento americano, in punto di volumi, sta calmierando il mercato mondiale.(…)
La produzione americana dal 2005 al 2012 è cresciuta di circa 1,5 milioni di barili/giorno. La previsione Weo gliene accredita circa altri 2,5 al 2020, e poi un declino di un paio di milioni di barili/anno negli anni che si avvicinano al 2035.
I consumi americani dal 2005 al 2012 sono scesi di due milioni e mezzo di barili giorno. Da qui al 2020 sono previsti ridursi di un altro milione scarso; e però di altri quattro dal 2020 al 2035. Forse nel parlare comune rischiamo di sottovalutare il ruolo patriottico della domanda.
Stiamo parlando di liquidi, che il gas è un’altra cosa. Il gas serve sempre più a fare energia elettrica, e compete in questo con carbone, idrico, nucleare, rinnovabili e quant’altro. La sua è stata la vera rivoluzione produttiva. Un salto dal 2005 al 2011 del 25%, da 511 miliardi di metri cubi prodotti nel 2005 a 651 nel 2011. Con la produzione davvero al minimo storico nel 2005; e che in coincidenza forse non spuria con la semplificazione delle normative ambientali comincia a rimbalzare già dal 2006. I consumi crescono, ma più lentamente. Da 623 a 690. Qui al lordo del Canada l’«indipendenza» è raggiunta già nel 2009-10. Eppure all’epoca c’è stato meno frastuono che non per l’annuncio di adesso di una possibile indipendenza petrolifera futura (e peraltro – 2035 – non imminente). Non è perché gli arabi sono un security threat quando devono caricare petroliere e meno quando devono approvvigionare di gas naturale liquefatto. La differenza, anzitutto, è funzionale.
Del gas puoi fare (in parte) a meno. Quasi tutto quello che fai con lui puoi farlo col carbone. Che magari sporca un po’ di più; ma in America ce ne è ancora tanto. In fondo gli Stati Uniti sono l’unico paese dove il sorpasso del gas sul carbone si è mostrato reversibile. Nel senso che il carbone dopo essere stato sorpassato una prima volta dal gas riuscì un po’ per cattiva regolazione e un po’ anche per lobby a risorpassarlo. È anche per questo che essere gas independent ti fa contento; ma non sei sicuro che ti cambi la vita.
Il petrolio invece no. Lui per ora non ti riesce di cambiarlo. È ancora insostituibile al sopravvivere del modello americano. Trasporto da punto a punto; e perciò trasporto su gomma; e perciò automobile. Ci si sta provando a trovare altro da mettere in serbatoio, dalla pila al gas a persino l’idrogeno. Lui, forte della sua densità energetica e perciò della sua portabilità, resiste. E tutto suggerisce che la sua insostituibilità per il modello, seppur erosa, resisterà a lungo. Onde si spiega perché il potenziale di diminuzione della domanda si riveli tendenzialmente più ampio del potenziale connesso alla crescita della produzione.
Il 50% del petrolio del mondo se ne va in trasporti. Ed oltre il 65% di quello americano. Un secolo di dominio sugli idrocarburi li ha fatti convivere con l’idea che l’energia fosse un bene se non comune almeno quasi gratuito; e hanno strutturato di conseguenza abitacoli e motori. Il consumo come variabile indipendente. (…)
Il mercato americano è anche (relativamente) isolato. Per il gas l’import/export, al lordo del Canada, è oggi praticamente nullo; giusto una decina di miliardi di metri cubi di importazione su quasi 700 di consumo. Per i liquidi, sempre al lordo del Canada, ci si sta avvicinando al 60% di autoproduzione, con l’export per adesso limitato ai prodotti. Insomma una condizione di assoluta autonomia per il gas dal mercato mondiale; e di autonomia relativa per i liquidi.
L’autonomia del mercato si manifesta in forma di autonomia del processo di formazione dei suoi prezzi. Oggi sembra generare risultati opposti a quelli figli del protezionismo. In rapporto al resto del mondo, il prezzo americano si è divaricato, e profondamente, verso il basso. L’isolamento ha accresciuto, anziché deprimere, concorrenza ed efficienza. Il protezionismo era difesa di una rendita. L’isolamento sembra quasi far emergere un elemento di rendita implicito al “mercato”. In isolamento si produce petrolio da un paniere che dovrebbe avere un costo di produzione ponderato più alto rispetto al resto della produzione mondiale; e però lo si vende a prezzo più basso. Forse l’oligopolio dei grandi produttori un effetto di sostegno-prezzo sul prezzo mondiale ce lo riesce ancora ad avere.
I numeri sono impressionanti. Già per il petrolio. Il cui prezzo sperimenta «its total disconnection from the global oil price-currently $ 22/bbl discounted for the same quality barrel of crude oil» (Deutsche Bank). E ai limiti dell’incredibile per il gas. Che non è comunque un mercato globale, ma tuttora regionale. E dove però i differenziali regionali sono stupefacenti. Rilevazione dei prezzi per gas naturale liquefatto di giugno 2012. Un milione di btu in America, a Henry Hub, lo compravi a 2 dollari e 10; in Inghilterra a 9,90; in Mediterraneo a 12; e in Asia a 17,40.
Giugno 2012 è una punta. Ma l’andamento medio è molto netto. Il gas naturale negli Stati Uniti costa meno della metà dell’equivalente europeo.E anche il petrolio non è proprio uguale. (…)
Gas e petrolio ci dicono insieme che il risorgimento ha fatto da calmiere sui volumi; ma anche che l’effetto calmiere sui prezzi per adesso riescono a tenerselo in buona parte per se stessi e ben dentro l’America.
Durerà? O ci sarà riallineamento? È il tema vero del risorgimento americano. (…)
Magari il differenziale di prezzo si lima; ma almeno per un po’ al meglio si assottiglia, e per certo non si dovrebbe annullare.
Dici security. Dici indipendenza. In realtà stai dicendo vantaggio competitivo. Non è «rivoluzione» perché la produzione aumenta; è rivoluzione perché l’aumento della produzione ha generato il differenziale, e potrebbe mantenerlo. «The United States will then have low-cost energy supplies for decades. (…) South Korea (…) China and Europe (…) will have to pay more, and the competitive advantage will make it possible for the United States to remain the global economic leader» (Verleger). Il petrolio che si ripete, nel secolo dopo, come fonte della leadership; e la ripetizione che non sembra farsa.
Un sistema economico che può fare il pieno di energia (fossile) a forte sconto sul resto del mondo. Questa è la novità. E se continua, è novità che potrebbe determinare gli equilibri di questo inizio secolo. Perfino l’Italia se ne godesse cambierebbe faccia. Un 10-15% (ponderando il costo dell’importato) di costo del petrolio in meno potrebbe fare, a spanne, quasi mezzo punto di pil in più. E il gas che costa il 50% in meno di adesso ci cambierebbe forse la vita industriale. I ceramisti di Sassuolo che si moltiplicano; l’alluminio che se proprio ci tieni puoi continuare a produrlo; e un margine operativo sull’acciaio che rischia di bastarti a finanziare la bonifica. Questa, applicata a noi, la dimensione del vantaggio.
Come se lo spenderanno loro è difficile predire. Del dominio nell’altro secolo hanno fatto nazionalismo, e non solo energetico. Del risorgimento è troppo presto per dire. Non farà rinascere la Pittsburgh tutta acciaio, che la riproposizione di un modello Energy Intensive non è culturalmente sostenibile. Però il sistema produttivo americano ha un volano per ripartire. E pare in effetti stia ripartendo. La ripresa, persino in un pezzo di Occidente, può non essere giusto una parola.
Poi ci sono gli altri. E come reagiranno. Il petrolio autarchico che costa meno che al mercato rischia di obbligare a ripensarsi. La Cina ha un immenso potenziale di unconventional. Per il gas sta cominciando a lavorarci. Per il petrolio Weo le accredita, nel 2035, una produzione di liquidi unconventional di giusto un milione di barili/giorno. Se il differenziale si mantiene, magari la predizione sfuma; e ne produrranno molti di più, e molto prima.

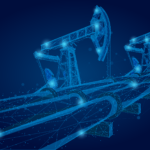
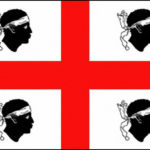














La grande risorsa energetica del Nord America è rappresentata dagli scisti bituminosi che possono essere sfruttati attraverso la tecnica della fratturazione idraulica. Peccato che ad oggi l’impatto ambientale sia pesantissimo per il consumo di acqua, l’inquinamento superficiale e per l’aumento della sismicità. C’è una sola via per conciliare indipendenza energetica e ambiente: il miglioramento delle tecniche estrattive e delle tecnologie di trattamento in superficie dei materiali contaminati. Già in questi ultimi anni sono stati compiuti progressi sia nei poppant che nei composti chimici impiegati con riduzione della quantità di acqua iniettata nel sottosuolo. Petrolio e gas “non convenzionali” possono cambiare la geostrategia energetica.
Vi sono poi risorse importanti di tipo convenzionale che possono essere estratti in acque profonde dalla piattaforma continentale atlantica e pacifica e nel mare di Beaufort. Anche qui la sfida è legata alla sicurezza ed alla economicità delle tecnologie estrattive.
Veramente si dice American OIL.
Petroleum e’ un termine più tecnico e inglese.
Per il trattamento delle acque reflue oleose si è realizzato un sistema chimico/fisico/biologico che può sostituire i bacini di decantazione basati sullo standard API 650. Ideale specialmente per risolvere i problemi derivanti nei scisti bituminosi.
Grandissimo saggio, anche se mal tradotto. Questi sono i veri drivers della storia
Articolo bellissimo, davvero molto interessante e con tanti spunti primo fra tutti la contraddizione di chiudersi al mercato che fa ridurre i prezzi invece di aumentarli… Scritto anche molto bene e quindi piacevole da leggere!
Manca però una pagina che può in breve tempo cambiare tutte le conclusioni e stravolgere per sempre questo mercato: le LENR e in particolare l’e-cat! Presto ne sapremo di più!
La apparente contraddizione di chiudersi al mercato che fa ridurre i prezzi invece che aumentarli è dovuta al fatto che negli USA ciò che si trova nel sottosuolo è di proprietà del proprietario del terreno mentre altrove, Italia compresa, il sottosuolo è pubblico; questo è perlomeno ciò che so.
Ciò permette la nascita di produttori indipendenti svincolati dalle major, una maggiore competizione ee quindi un calo dei prezzi.
Vallo a spiegare ai sostenitori dello statalismo.
Esatto Vincenzo. Nicolazzi lo spiega nel suo libro edito boroli.
@Jack Monnezza
si trattava di una citazione, caro Monnezza. Negli Usa c’è l’American Petroleum Institute, che rappresenta le società del settore…
Un’analisi molto interessante.
Per quanto riguarda lo Shale-Gas, questo ha determinato il crollo dei prezzi che Massimo Nicolazzi ricordava sopra: ” … Un milione di btu in America, a Henry Hub, lo compravi a 2 dollari e 10; in Inghilterra a 9,90; in Mediterraneo a 12; e in Asia a 17,40. ”
Attenzione però a non illudersi che il basso prezzo negli USA (peraltro insostenibile a breve-medio termine), non potrà avere alcun effetto sulla discesa dei prezzi del Gas in Europa, neppure se gli USA cominceranno ad esportare parte di quello Shale-Gas in forma di LNG, perchè al prezzo sul mercato usa si dovranno aggiungere i costi di: liquefazione, trasporto e rigassificazione, oltre alle inevitabili perdite conseguenti. Quindi un eventuale import di LNG dagli USA potrà solo rappresentare una marginale alternativa, non l’allineamento dei prezzi con gli USA.
Circa l’impatto ambientale, attenzione a non farsi confondere le idee (come spesso si legge) perchè l’impatto dello Shale-Gas sulle emissioni di CO2 non è proprio trascurabile. Al riguardo suggerisco di andare a leggere lo Studio della Cornell University – Ithaca/USA ( http://www.eeb.cornell.edu/
howarth/CCSP%20letter%20on%20energy%20&%20environment.pdf ) dove si parla dell’impatto del solo “Methane and the greenhouse-gas footprint of natural
gas from shale formations” e dove si chiarisce anche qual’è la reale equivalenza in termini di GHG del Methano rispetto alla molecola di CO2, ben diversa da quanto ci hanno raccontato finora gli scienziati dell’ ONU-IPCC. Quindi per nulla vero che gli USA abbiano ridotto le loro emissioni di GHG grazie alla parziale sostituzione del Carbone con il Gas.